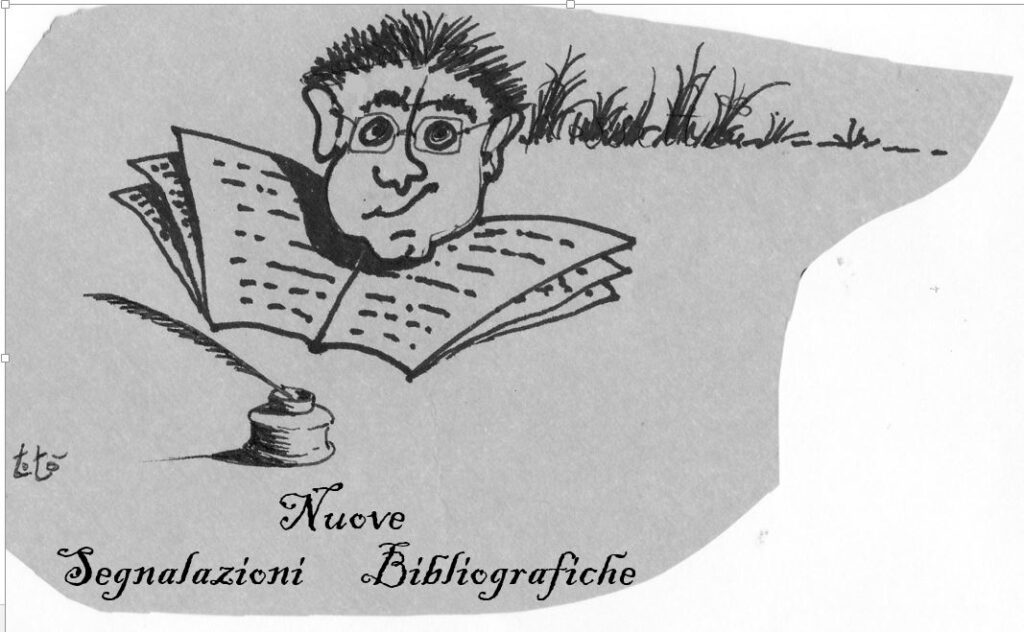di Rosario Coluccia

I dizionari italiani vantano una tradizione plurisecolare che ha il suo fondamento illustre nell’attività lessicografica dell’Accademia della Crusca, fondata a Firenze nel 1583. Obiettivo primario di quel gruppo di intellettuali, che sapevano unire lungimiranti iniziative culturali a piacevoli serate di bisboccia condite da esibizioni poetiche (gli «stravizzi» e le «cicalate»), fu la compilazione di un vero e organico dizionario della nostra lingua. Quell’opera collettiva fu realizzata da un gruppo composito, non tutti erano specialisti forniti di specifiche competenze linguistiche. Ma «il lavoro fu condotto con una coerenza metodologica e un rigore che andavano al di là di tutti i precedenti» (sono parole di Claudio Marazzini, presidente onorario dell’Accademia, che alla storia del vocabolari italiani ha dedicato un libro molto informato e puntualissimo).
Fin dagli inizi, con la sua attività lessicografica l’Accademia si assumeva lo scopo fondamentale di separare il fior di farina (la buona lingua) dalla crusca, dando quindi un significato preciso alla propria denominazione. Il frullone, lo strumento che si adoperava per separare il fior di farina dalla crusca, simboleggiava questa scelta, ricordata anche dal motto adottato, il verso del Petrarca «il più bel fior ne coglie». Tutti gli oggetti e la mobilia dell’Accademia ebbero nomi attinenti al grano, alla crusca, al pane, compresi gli stemmi personali degli accademici, le pale di legno in cui è dipinta un’immagine accompagnata dal nome accademico e dal motto scelto. Se ne sono conservate 152, realizzate dalla fondazione fino alla metà del secolo XVIII, che si si possono ammirare nella cosiddetta “Sala delle pale” (anche al sito www.accademiadellacrusca.it/it/contenuti/la-sala-delle-pale/6943); alle antiche di aggiungono ora le moderne, conservate in una diversa sala della splendida Villa Medicea di Castello, a Firenze, sede attuale dell’Accademia. Elementi esterni fortemente simbolici e significativi.